LE
ORCHIDEE
<
Torna indietro
Le Orchidee spontanee sono fiori
dotati di uno straordinario fascino, non solo per la loro bellezza,
ora intrigante ora sorprendente per le peculiarità metaforiche
delle forme,  ma anche per le loro strategie riproduttive che rivelano un'intelligenza
ed un'astuzia più caratteristiche del mondo animale che di
quello vegetale. In realtà la loro evoluzione ha viaggiato
per milioni di anni andando di pari passo con quella degli insetti
impollinatori.
ma anche per le loro strategie riproduttive che rivelano un'intelligenza
ed un'astuzia più caratteristiche del mondo animale che di
quello vegetale. In realtà la loro evoluzione ha viaggiato
per milioni di anni andando di pari passo con quella degli insetti
impollinatori.
Le Orchidee esotiche hanno dimensioni
più grandi e sono per lo più epifitiche, ossia crescono
sugli alberi. Quelle europee sono invece terricole ed hanno dimensioni
più piccole, ma non sono affatto meno belle.
Alla famiglia delle Orchidee, che
è una delle più numerose del mondo vegetale appartengono
più di 20.000 specie distribuite su tutta la superficie del
globo con esclusione degli artici e dei deserti.
In
Sicilia ne sono presenti oltre 60 entità, fra specie e subspecie
e di queste 47 si riscontrano nella Sicilia sud orientale. Le Orchidee
adottano un metodo di riproduzione entomofila, ma attraggono gli
insetti pronubi con strategie diversificate per genere.  Tutte comunque producono numerosissimi e minuti semi sprovvisti
di sostanza citoplasmatica. Per questo motivo essi allignano soltanto
quando trovano dei microfunghi con i quali instaurano un rapporto
simbiotico che ne permette la germinazione, il seme fornisce il
motore metabolico e il programma riproduttivo impresso nei geni,
mentre il fungo provvede a rifornire la cellula del substrato energetico.
Questo rapporto può durare per tutta la vita per quelle specie
saprofitiche incapaci di sintesi clorofilliana, mentre per la maggior
parte delle altre specie idonee alla sintesi clorofilliana, si interrompe
quando la plantula produce le prime foglie verdi capaci di captare
la luce del sole.
Tutte comunque producono numerosissimi e minuti semi sprovvisti
di sostanza citoplasmatica. Per questo motivo essi allignano soltanto
quando trovano dei microfunghi con i quali instaurano un rapporto
simbiotico che ne permette la germinazione, il seme fornisce il
motore metabolico e il programma riproduttivo impresso nei geni,
mentre il fungo provvede a rifornire la cellula del substrato energetico.
Questo rapporto può durare per tutta la vita per quelle specie
saprofitiche incapaci di sintesi clorofilliana, mentre per la maggior
parte delle altre specie idonee alla sintesi clorofilliana, si interrompe
quando la plantula produce le prime foglie verdi capaci di captare
la luce del sole.
Perché si instauri questo
rapporto simbiotico di tipo micorrizico possono trascorrere da 2
a 15 anni e questo dato già contribuisce in parte al rispetto
per le orchidee spontanee che in un certo senso affidano la loro
riproduzione alla aleatorietà della sorte. Ophrys mirabilis
appartiene ad un genere che, non essendo provvisto di organi produttori
di sostanze zuccherine (sperone nettarifero), ha elaborato un espediente
alternativo raffinato ed intelligente di attrazione per i pronubi.
Le Orchidee di questo genere infatti possiedono un labello (petalo
specializzato) con la forma, il colore, la pelosità e persino
gli odori caratteristici (feromoni) delle femmine di determinati
insetti esclusivi per ciascuna specie.
Così gli insetti maschi vengono
attratti dalle sembianze femminili del labello e vi si buttano addosso
a capofitto, cercando freneticamente un abbraccio amoroso (pseudocopulazione).
In questa foga di sfrenata passione vengono a contatto con i bottoncini
adesivi (viscidii o retinacoli) dei pollinodi che rapidamente aderiscono
al loro corpo.
Successivamente gli insetti maschi,
un po' delusi dalla scarsa partecipazione femminile s'involano alla
ricerca di un'altra femmina (o presunta tale) e molto probabilmente
ricadranno nell'inganno fecondando però in tal modo un'altra
orchidea.
 Come
tutte le Ofridi, anche Ophrys mirabilis adotta la medesima strategia
riproduttiva. Il successo di un tale comportamento di attrazione
sessuale si misura dal numero di ovari fecondati e purtroppo pare
da una recente stima effettuata nel corso dell'ultima stagione di
fioritura, che Ophryis mirabilis da questo punto di vista non abbia
molto successo. Come
tutte le Ofridi, anche Ophrys mirabilis adotta la medesima strategia
riproduttiva. Il successo di un tale comportamento di attrazione
sessuale si misura dal numero di ovari fecondati e purtroppo pare
da una recente stima effettuata nel corso dell'ultima stagione di
fioritura, che Ophryis mirabilis da questo punto di vista non abbia
molto successo.
Quest'anno infatti gli ovari fecondati
di O. mirabilis iblea che hanno fruttificato sono stati circa il
30%. Questo dato fa temere il peggio per la nostra Orchidea. Anche
se non si è in grado di sapere quale sia stato nel passato
il tasso di fruttificazione si può supporre che il successo
riproduttivo dei suoi comportamenti sessuali non sia in assoluto
elevato anche confrontandolo con quello di altre Ofridi presenti
nello stesso sito ed in cui ho potuto constatare un tasso di fruttificazione
dell'80% in media e del 100% in alcuni individui. Nessuna O. mirabilis,
fra le 40 esaminate, ha presentato l'anno scorso fruttificazione
di tutti gli ovari.
La causa più probabile di
questo fenomeno potrebbe essere attribuita o ad una diminuzione
del numero di insetti pronubi specifici, causata da modificazioni
dell'ambiente (realmente indotta dall'intervento umano nell'ultimo
decennio in quella località) oppure da una diminuzione della
forza seduttiva dei feromoni o delle fattezze del labello di O.
mirabilis.
In considerazione comunque della
cospicuità della popolazione di O. mirabilis sembra opportuno
ipotizzare come più realistico un evento suscettibile di
modificazione a breve termine piuttosto che altri legati a fattori
genetici che necessitano di tempi molto lunghi e la cui trasformazione
avrebbe già determinato un impoverimento della popolazione.
Ciò probabilmente non è
ancora avvenuto trattandosi di piante perennanti, ma potrebbe avvenire
in un prossimo futuro.
O. mirabilis appartiene al genere
O. e al gruppo di O. fusca-lutea senza solco mediano basale, analogamente
a O. atlantica e al sottogruppo di O. omegaifera. Queste orchidee
per molti versi assomigliano alle Ofridi del gruppo Ophrys fusca-lutea,
ampiamente diffuse in Sicilia, ma se ne distinguono per l'assenza
del solco mediano alla base del labello e per la presenza di un
margine chiaro apicale dello specchio a forma di w (come nel sottogruppo
di Ophrys omegaifera).
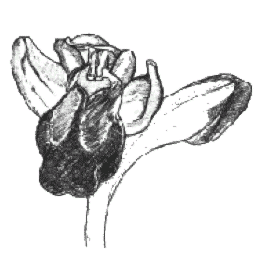
Ophrys fusca; con solco basale mediano
Le Orchidee con queste caratteristiche,
prima della scoperta di Ophrys mirabilis, erano presenti solo nel
territorio nord-africano e in quelle regioni mediterranee in cui
la sua influenza è più forte: a Occidente il sud della
penisola iberica (O. dyris, O. atlantica) e ad Oriente la Grecia,
Creta, Libano e Israele (O. israelitica, O. omegaifera etc.).
La scoperta di questa nuova stazione
di O. mirabilis offre l'occasione per confermare ancora una volta
la grande importanza che ha dal punto di vista biogeografico la
cuspide meridionale della Sicilia in cui convergono le influenze
delle regioni orientali e occidentali del mediterraneo e del Nord
Africa.
E di questa realtà biologica
O. mirabilis diviene un simbolo elegante e sorprendente da proteggere
e salvaguardare perché la sua esistenza conferma una volta
di più che la Sicilia "costituisce un mondo insulare
di profonda originalità e di incredibile diversità".
(P. Geniez e F. Melki)
|

